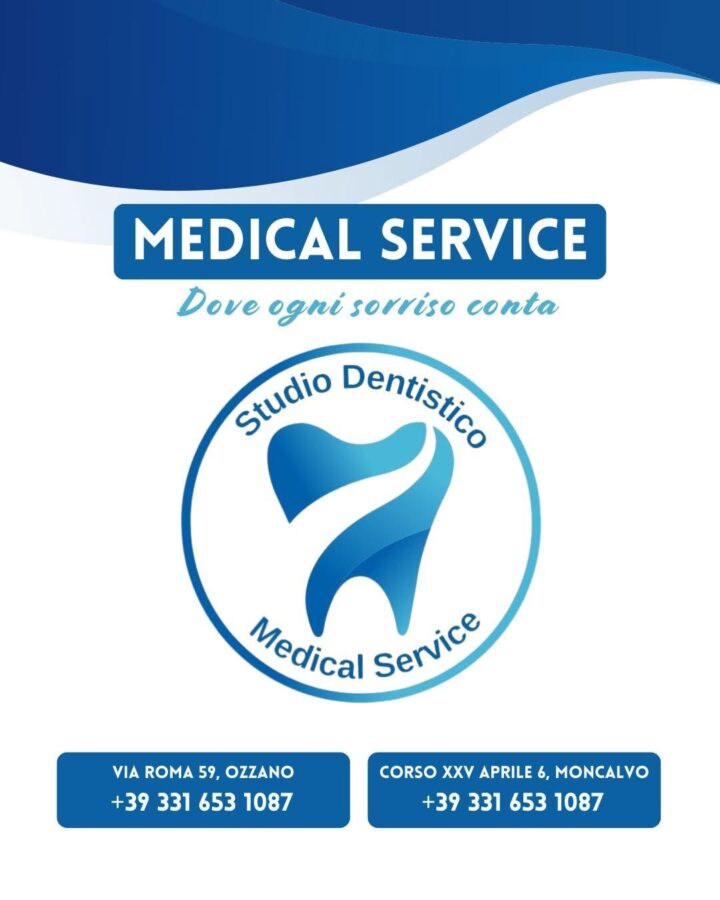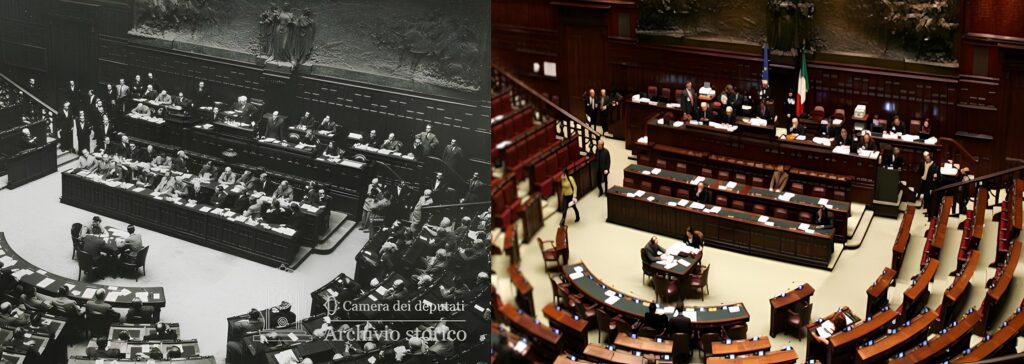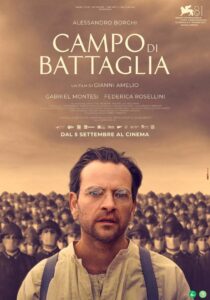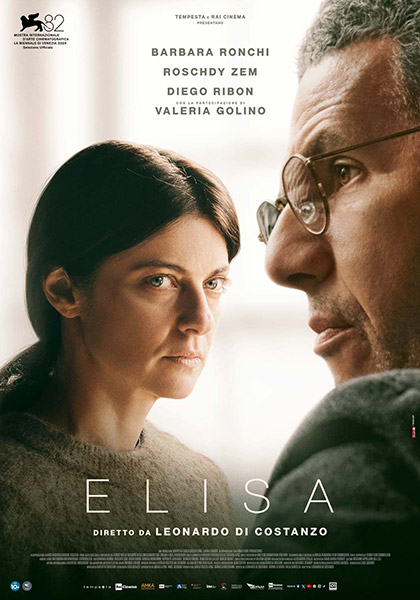di Danilo Narduzzi

La prima volta che sentì pronunciare quello strano nome (Bus de la lum) fu dall’amico e ricercatore storico Marco Pirina. Un uomo che, negli anni bui della “negazione e del silenzio”, pubblicava tra mille polemiche libri sulla tragedia misconosciuta delle “foibe”. Basti dire che a quel tempo (1991), studiavo ancora storia all’Università e non mai avevo sentito parlare di queste “foibe”: inghiottitoi carsici, profonde grotte naturali dell’Istria e della mia regione, il Friuli Venezia Giulia, dove durante e soprattutto alla fine della Seconda guerra mondiale venivano gettati dai partigiani titini (ma anche a volte da quelli italiani) “quelli che stavano dall’altra parte”: prigionieri tedeschi, sospetti fascisti o anche semplici civili, solo perché italiani.
Fu così che entrai a far parte dell’associazione “Silentes Loquimur”, fondata da Marco Pirina, e che voleva dar voce a chi voce non aveva più. Raccontare le storie smarrite, le pagine omesse, che non avevano diritto di entrare nei libri di scuola.
Ricordo ancora la prima volta che Marco mi portò a vedere Il Bus della lum (“in dialetto vuol dire il Buco della luce”, mi disse, “vedrai coi tuoi occhi di cosa si tratta”). Dopo aver raggiunto il Pian del Cansiglio, comune di Caneva, provincia di Pordenone, parcheggiammo l’auto ed entrammo subito nella foresta.
Pirina si muoveva sicuro tra la vegetazione e in breve tempo, seguendo un sentiero appena accennato e poi un piccolo rivolo d’acqua, giungemmo all’imbocco di quella cosa. La vista di quell’antro nero, circondato solo a tratti, da un arrugginito filo spinato, ebbe ai miei occhi un effetto sconvolgente. Quel suo occhio enorme e buio sembrava guardarmi con malignità.
“Qui furono gettati centinaia uomini e donne: soldati tedeschi e italiani, carabinieri, finanzieri, civili accusati di essere amici dei fascisti o anche solo per regolamenti di conti per faccende di vecchi sgarbi, donne o soldi”, mi disse, “alcuni certamente ancora vivi”.
In effetti, avevo letto la settimana precedente alla visita, di alcune testimonianze sulle foibe del Carso, che spiegavano come i prigionieri fossero legati l’uno all’altro con fil di ferro e portati davanti al pozzo. Al primo sparavano un colpo in testa e con un calcio le gettavano nello strapiombo, così il poveraccio si trascinava dietro tutti gli altri dannati ancora vivi e urlanti. Era l’altra faccia dell’orrore, che i nazi-fascisti avevano usato durante la guerra contro la Resistenza e che ora i partigiani comunisti ripetevano. Odio contro odio. Ferocia contro ferocia. Dolore che si sommava ad altro dolore.
Il pensiero che anche quei disgraziati, colpevoli o no di qualcosa, avessero visto quell’occhio malvagio guardarli con avidità, pochi istanti prima di essere gettati nelle sue profondità, era angosciante. Mi sembrava quasi sentire le loro preghiere disperate, per essere risparmiati, magari in nome dei loro figli che li aspettavano a casa…e poi le grida di terrore e dolore, i tonfi sordi, i lamenti dei feriti in fondo al pozzo, che risuonavano cupi da quella gola infernale.
Eppure, quel giorno d’estate in cui eravamo andati là, la natura intorno al “Buco di luce” era così bella. Di una bellezza misteriosa, ma bella. I richiami degli uccelli, qualche farfalla bianca sulle strette radure che a volte si aprivano improvvisamente tra la vegetazione, qualche piccolo fiore azzurro che cresceva sul margine del pozzo. Come a significare che la vita vuol sempre trionfare sulla morte, la bellezza sull’orrore.
Antichi miti e leggende popolari, forse dei Celti, che avevano un tempo abitato questo altopiano, raccontavano che un tempo molto lontano abitassero i quei boschi sacri delle ninfe chiamate “Aganis”. Alcuni dicevano fossero ninfe dotate di poteri e buone d’animo, ma che col calare del sole, o se stuzzicate da persone malvagie, potevano diventare molto cattive e pericolose. (Altre storie invece, raccontavano che queste creature del bosco fossero delle vere e proprie streghe). Ma tutte le leggende concordavano sul fatto che queste creature misteriose, la notte, si rifugiassero nelle profondità di quel Buco e che lì cuocessero il loro pasto. Questo, sostenevano i tagliaboschi, era il motivo per cui si vedeva alcune notti un bagliore brillante venire dalla profondità del Bus de la lum.
Questo è solo un piccolo ricordo di quella prima volta che andai in quel posto così denso (ancora oggi) di umana sofferenza e speranza. Ma da allora, ogni anno ci ritorno al Bus de la lum. Porto con me un fiore e una preghiera per quelle povere anime a ricordare la loro sventura, con la speranza che oggi riposino in pace.
Marco Pirina mancò improvvisamente nel 2011, mentre stava facendo delle ricerche storiche nel Bellunese per un suo nuovo libro. Al di là di ogni giudizio o posizione politica, rimane di lui il ricordo di uno storico che non ha avuto paura di sporcarsi le mani con documenti scottanti, che molti storici di professione fingevano di non vedere. Fu instancabile nella continua ricerca di prove e testimonianze di chi la guerra l’aveva vissuta sulla propria pelle, anche per dare un nome e un volto a chi era stato inghiottito dalle foibe, nel dimenticatoio delle violenze storiche seguite alla fine della guerra.
E’ anche grazie a lui e a quelli come lui se oggi i libri di storia nelle scuole d’Italia possono ospitare anche la voce di coloro che voce non avevano più, “Silentes Loquimur”.