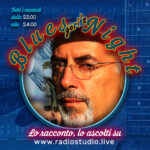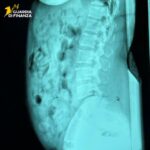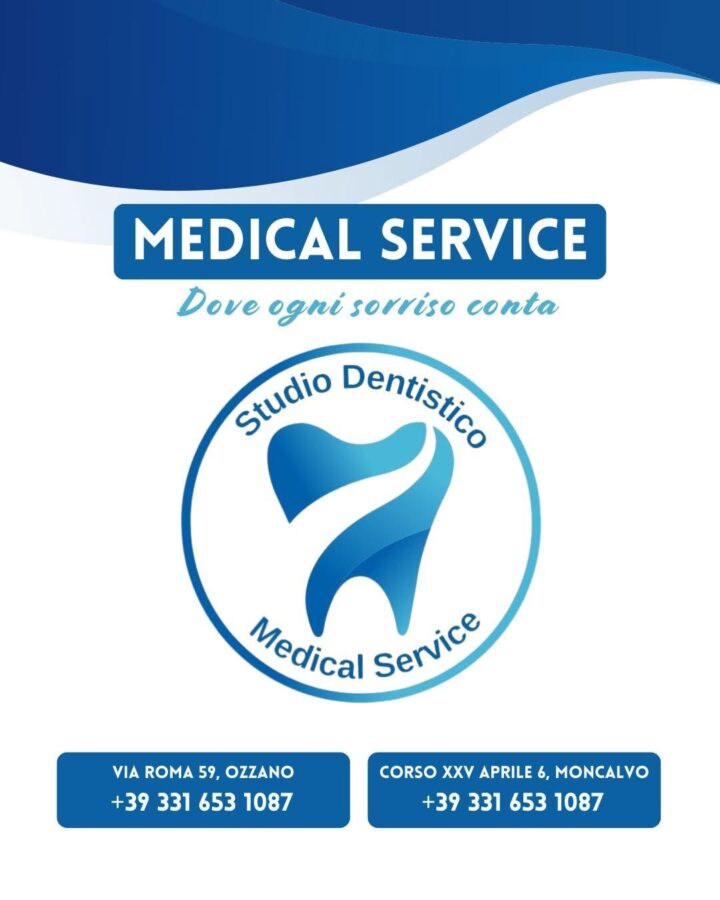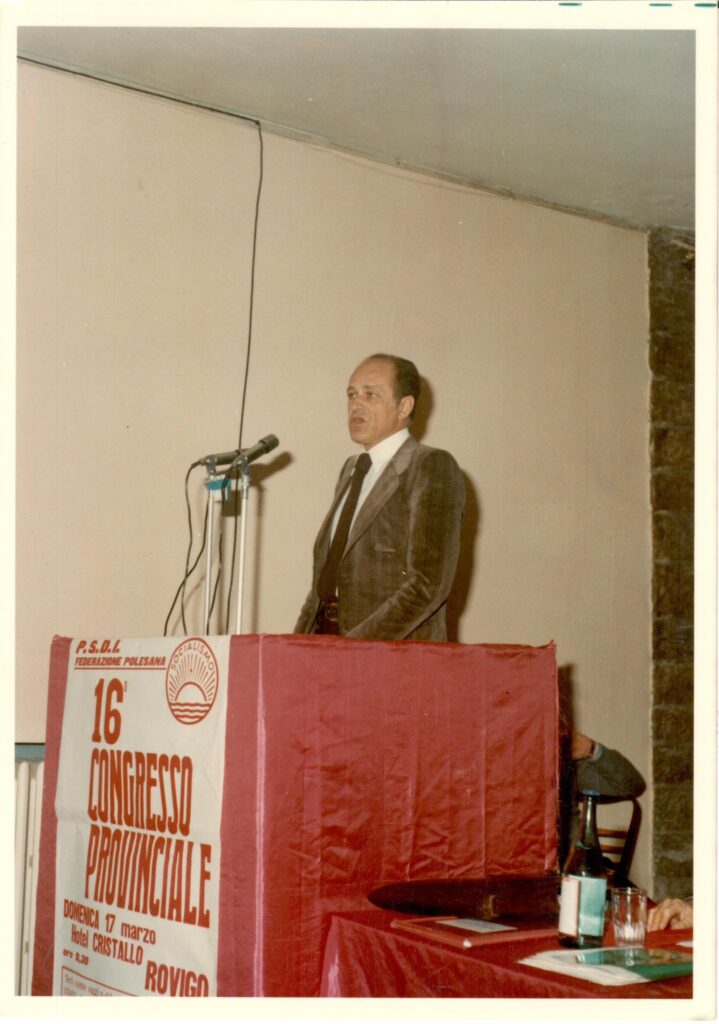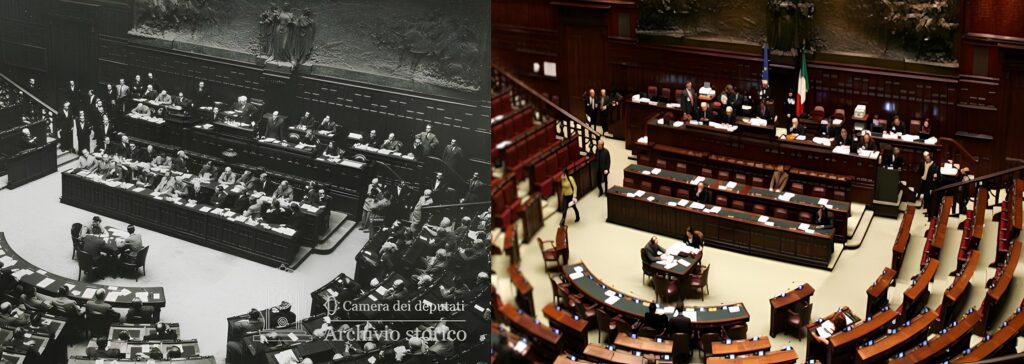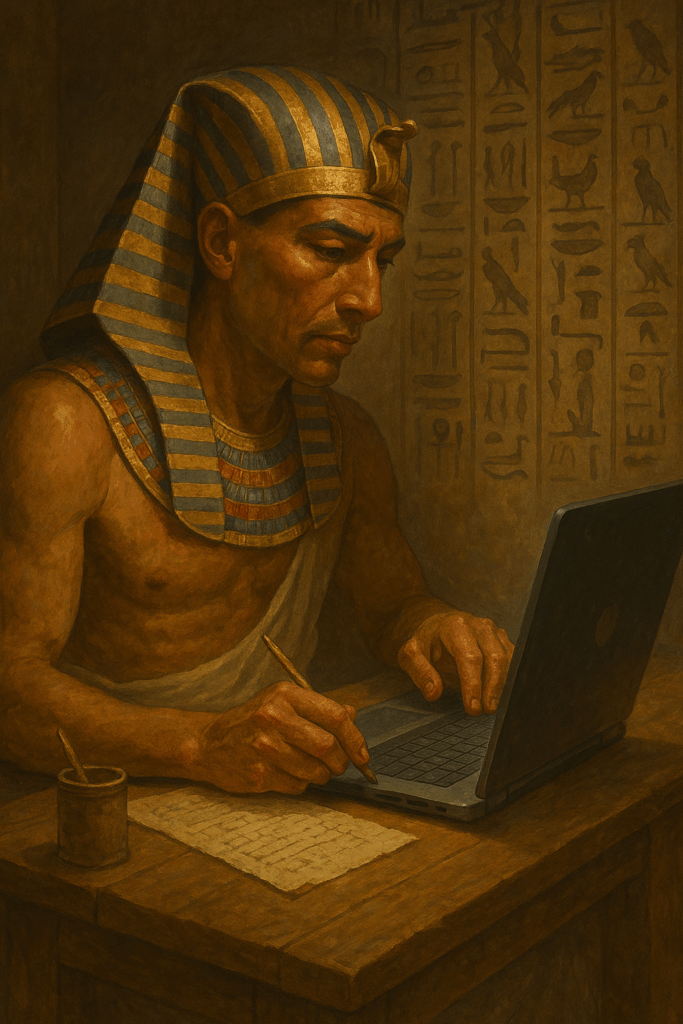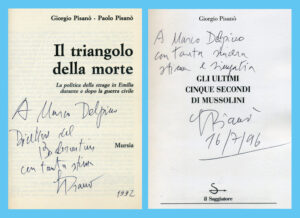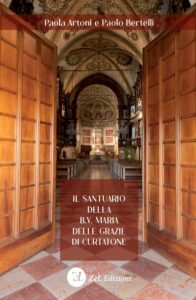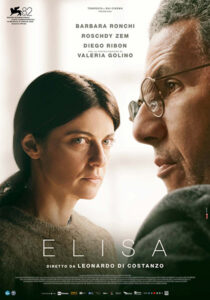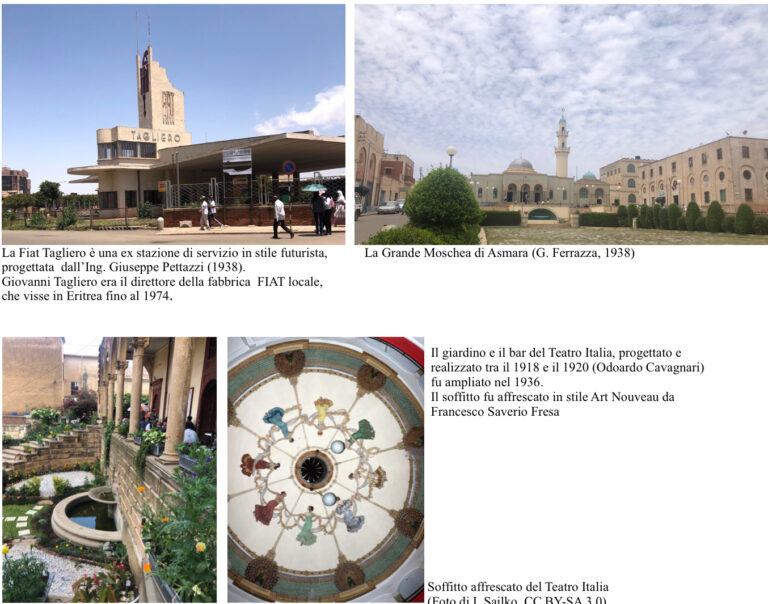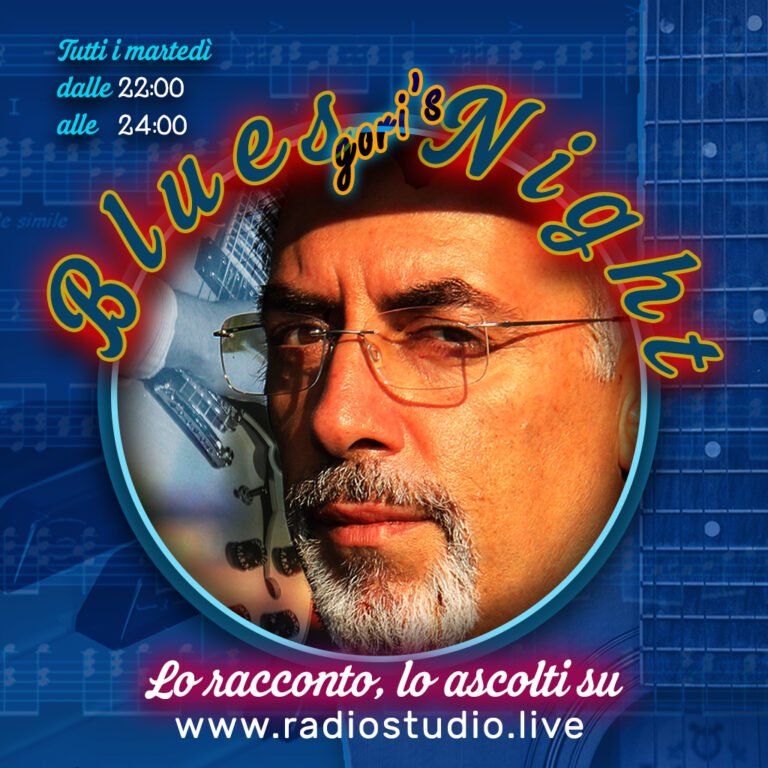di Matteo Rigamonti

La comunicazione è una delle sfide più affascinanti e complesse della nostra epoca. Viviamo immersi in un mondo in cui l’informazione circola alla velocità della luce, i contenuti si moltiplicano in tempo reale, e l’accesso alla conoscenza è, almeno in teoria, alla portata di tutti. Da un lato, abbiamo creato macchine e sistemi avanzati che gestiscono l’informazione in modo impeccabile; dall’altro, l’essere umano continua a inciampare in incomprensioni, superficialità e fraintendimenti, sia nelle relazioni personali che in ambiti professionali.
Eppure, paradossalmente, la nostra capacità di comprendere ciò che leggiamo, ascoltiamo o osserviamo sembra regredire. Il caso recente della sindaca di Merano, Katharina Johanna Zeller, ne è un esempio perfetto.
Un video virale la ritrae mentre si toglie la fascia tricolore durante una cerimonia pubblica. Il gesto, sobrio e pacato, ha scatenato un’ondata di indignazione da parte dell’opinione pubblica, amplificata da politici e commentatori. Titoli scandalizzati, appelli all’unità nazionale, richiami ai doveri istituzionali: la macchina dell’indignazione si è messa in moto con efficienza chirurgica. Eppure, pochi hanno sentito il bisogno di fare ciò che un tempo sarebbe stato considerato doveroso: approfondire.
La legge italiana, infatti, prevede che la fascia tricolore sia obbligatoria esclusivamente per le funzioni di stato civile (come matrimoni, giuramenti, ecc.) e non è affatto obbligatorio indossarla in altre circostanze. E qui si apre una riflessione più ampia. Chi oggi si erge a difensore dei simboli è spesso lo stesso che, per anni, ha abusato della forma che pretende di difendere. Ad esempio l’uso della fascia tricolore da parte di consiglieri o assessori in ruoli puramente rappresentativi è diventato prassi, nonostante sia vietato dalla normativa (come ribadito dal Ministero dell’Interno, parere DAIT n. 98732/2019). Chi oggi grida al vilipendio è spesso lo stesso che ha trasformato quel simbolo in una scenografia, in uno strumento di esibizione politica. Una forma, svuotata della sostanza.
A correggerla pubblicamente, con un tono paternalista e fuori luogo, è stato l’ex sindaco della città, il cui cognome richiama una struttura tipica di molte zone del Sud Italia. Una coincidenza simbolica non trascurabile, se consideriamo la storia del Sud Tirolo. Durante il fascismo, l’Alto Adige è stato oggetto di una violenta operazione di italianizzazione: sindaci e funzionari di lingua tedesca destituiti, scuole chiuse, toponomastica cambiata, lingua vietata. Ma soprattutto, una massiccia migrazione di funzionari, carabinieri e lavoratori dal Sud e dal Veneto fu incentivata per modificare l’equilibrio demografico del territorio.
Nessuna colpa individuale, ma una memoria collettiva che rimane viva. Ed è proprio da questa storia che nasce il valore profondo dell’autonomia altoatesina: un modello solido, condiviso, giuridicamente blindato. Qui, l’autonomia non è un tema di destra o di sinistra: è un diritto costituzionale difeso da tutte le forze politiche, come ha dimostrato anche la sindaca Zeller, politicamente distante da me ma profondamente coerente nel suo atteggiamento sobrio e istituzionale.
Questo episodio è anche un caso da manuale sulla superficialità della comunicazione moderna. Non solo per l’indignazione istantanea, ma per la totale mancanza di conoscenza delle regole e della storia di quel territorio. Si invoca la forma, ma la si storpia; si pretende il rispetto dell’istituzione, ma la si fraintende. Si grida al vilipendio senza sapere neppure che la fascia, fuori dai contesti previsti, è solo un simbolo standardizzato e non obbligatorio.
E qui emerge un secondo tema attuale: mentre l’essere umano, immerso in un’infodemia, cade nella trappola della semplificazione e dell’emotività, l’intelligenza artificiale – da molti temuta come strumento impersonale e disumanizzante – comunica senza alcuna intenzione manipolativa. I modelli linguistici generativi, per quanto imperfetti, restituiscono ciò che apprendono, senza secondi fini. Non è raro che a usarli con più efficacia siano persone senza titoli accademici, ma con grande capacità di approfondimento e di comprensione.
E allora sorge il vero paradosso: mentre alcuni accademici criticano questi strumenti per timore che possano livellare il sapere, spesso sono proprio loro a usarli in modo più superficiale, perché convinti che basti il titolo per comprenderli. In realtà, come nella comunicazione pubblica, anche nell’uso dell’intelligenza artificiale la differenza la fa sempre la volontà di approfondire. Non il titolo, ma la curiosità.
In un momento in cui i simboli vengono usati per creare pretesti, e la forma giuridica è invocata solo quando conviene, è doveroso ribadire che non è la forma il problema. È la sua caricatura. La sua storpiatura. Come sempre, con la caricatura di una forma non applicabile si tenta di dare sostanza a una polemica insensata e costruita ad arte come pretesto.