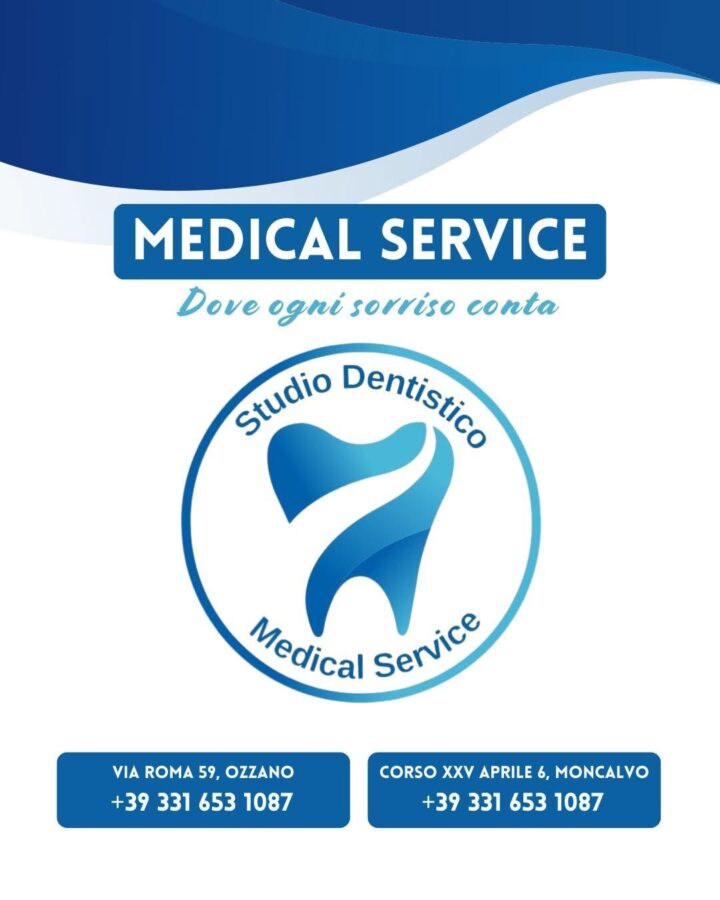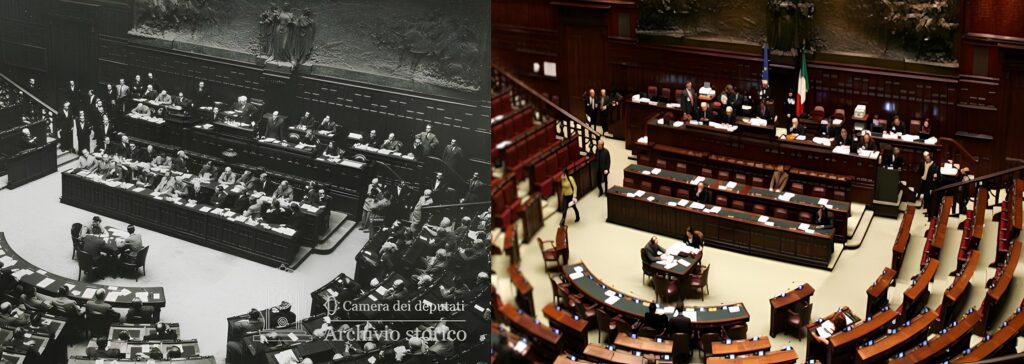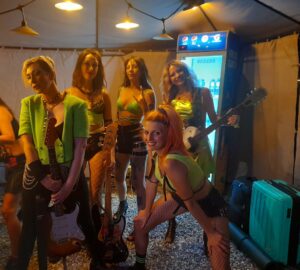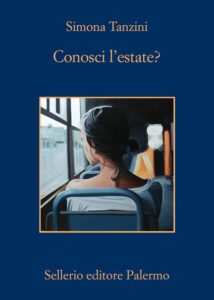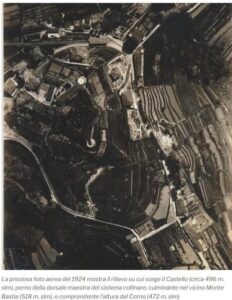In Svizzera, il 1° agosto è molto più di una data sul calendario: è festa nazionale e celebrazione delle origini della Confederazione. Al centro di questa narrazione si trova il leggendario Patto del Grütli, un giuramento di alleanza e libertà pronunciato, si dice, nel 1291 da tre uomini dei cantoni di Uri, Svitto e Untervaldo, affacciati sul prato sospeso sopra il Lago dei Quattro Cantoni.

Ma fino a che punto questo episodio, tanto evocativo quanto familiare, si fonda su fatti storici? E cosa racconta oggi, in una Confederazione che si estende fino al Ticino e guarda oltre le Alpi, verso la Lombardia?
Il racconto tradizionale ci parla di un incontro segreto tra rappresentanti di tre comunità alpine che temevano la crescente pressione degli Asburgo. Su un prato chiamato Grütli (Rütli), i protagonisti avrebbero stretto un giuramento di fedeltà e difesa reciproca. Da quell’accordo, trasmesso oralmente e poi elevato a simbolo nazionale, sarebbe germogliata l’alleanza che, secoli dopo, diventò la Confederazione Elvetica.
Questo momento mitico, ripreso nella letteratura romantica tedesca, scolpito nella storiografia ottocentesca e rievocato in ogni cerimonia nazionale, costituisce la base narrativa dell’identità svizzera moderna.

Vista sul lago di Lugano dalla cresta del Monte San Giorgio
La storia è, però, più complessa della leggenda. Lo storico svizzero Roger Sablonier (1941–2010), studioso del medioevo elvetico ha messo in discussione l’intero impianto simbolico del Patto del Grütli. Un approccio scomodo, che alcuni ambienti hanno giudicato eccessivamente provocatorio.
Nel suo libro “Gründungszeit ohne Eidgenossen” (Un’epoca di fondazione senza confederati), pubblicato nel 2008, Sablonier afferma che il famoso giuramento non è documentato e che l’intero racconto è una costruzione ideologica nata secoli dopo.

Dal Monte San Giorgio, vista sul Monte Generoso, montagna di confine tra Lombardia e Canton Ticino.
Secondo le sue ricerche, il Bundesbrief del 1291, spesso indicato come prova storica del giuramento, è in realtà un documento amministrativo, redatto probabilmente dopo il 1309, che nulla dice del Rütlischwur. Inoltre, descrive una Confederazione che non nacque con un unico atto fondativo, ma si sviluppò in modo graduale e frammentato, nel corso di oltre un secolo. Infine, sottolinea come la leggenda fu consolidata soprattutto nel XIX secolo, in pieno fermento nazionale, per fornire al giovane Stato federale un’origine comune e gloriosa.
Sablonier non demolisce il senso del mito, ma invita a distinguere tra storia e memoria, tra il bisogno di simboli e la realtà dei processi storici.

Panorama sulla Valsolda (ITA) dalla cima del monte Boglia, Prealpi luganesi (CH).
Se il Patto del Grütli riguarda l’Innerschweiz, il Canton Ticino resta ai margini della narrazione fondativa, ma non della storia.
Annesso alla Confederazione solo nel XV secolo come territorio soggetto (baliaggio), il Ticino condivideva già profondi legami culturali, economici e linguistici con la Lombardia. Le valli meridionali erano parte viva del sistema alpino, attraversate da merci, eserciti, idee e famiglie.
La Leventina, ad esempio, era un corridoio strategico tra Milano e i cantoni settentrionali. Locarno, Bellinzona, Mendrisio avevano rapporti più diretti con Como o Varese che con Zurigo o Lucerna. L’identità ticinese è quindi plurale per natura: svizzera per cittadinanza e sistema politico, italiana e lombarda per lingua, cultura e geografia umana.
Oggi, in un’Europa dai confini aperti, i rapporti tra Ticino e Lombardia si rinnovano nella forma di progetti transfrontalieri, scambi culturali, mobilità quotidiana. Ma le radici di questa relazione sono antiche, forse più profonde del Patto del Grütli e altrettanto fondative.

Oratorio di San Lucio tra la Val Cavargna (ITA) e Val Colla (CH).
Il 1° agosto resta una data simbolica fondamentale per la Svizzera. Ma guardare alla storia con spirito critico non significa togliere valore ai simboli, bensì comprenderne la costruzione e riscoprirne le radici autentiche.
Il Patto del Grütli, anche se forse non avvenne mai come lo immaginiamo, conserva ancora oggi un ruolo centrale nella memoria collettiva della Svizzera. È un simbolo potente, costruito nel tempo e consolidato soprattutto nel XIX secolo, in un’epoca in cui le giovani nazioni cercavano racconti fondativi capaci di rafforzare l’identità e l’unità interna.
Se si guarda oltre il mito, però, ciò che ha realmente tenuto insieme, nel tempo, le regioni alpine e prealpine è un lungo intreccio di relazioni storiche e scambi culturali. A unire i popoli delle Alpi, da Uri al Ticino, fino alle valli lombarde, è stata la storia vissuta più che la leggenda trasmessa: una storia fatta di autonomie locali e una fitta rete di interdipendenze economiche, linguistiche e culturali.

Erbonne (ITA) tra la Valle di Muggio e l’Alta Valle d’Intelvi.
In questo senso, il Patto del Grütli può essere letto oggi non tanto come un’origine da prendere alla lettera, ma come una metafora di un processo molto più ampio e complesso, che ha coinvolto anche terre poste ai margini della narrazione, come il Canton Ticino o la Lombardia settentrionale. Sono questi territori, spesso esclusi dal mito, ma mai dalla realtà storica, a ricordarci che l’identità di una nazione non si costruisce solo con simboli fondativi, ma soprattutto con le storie che resistono, si intrecciano e si trasformano nel tempo.