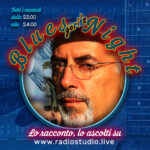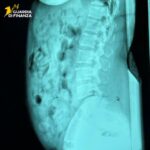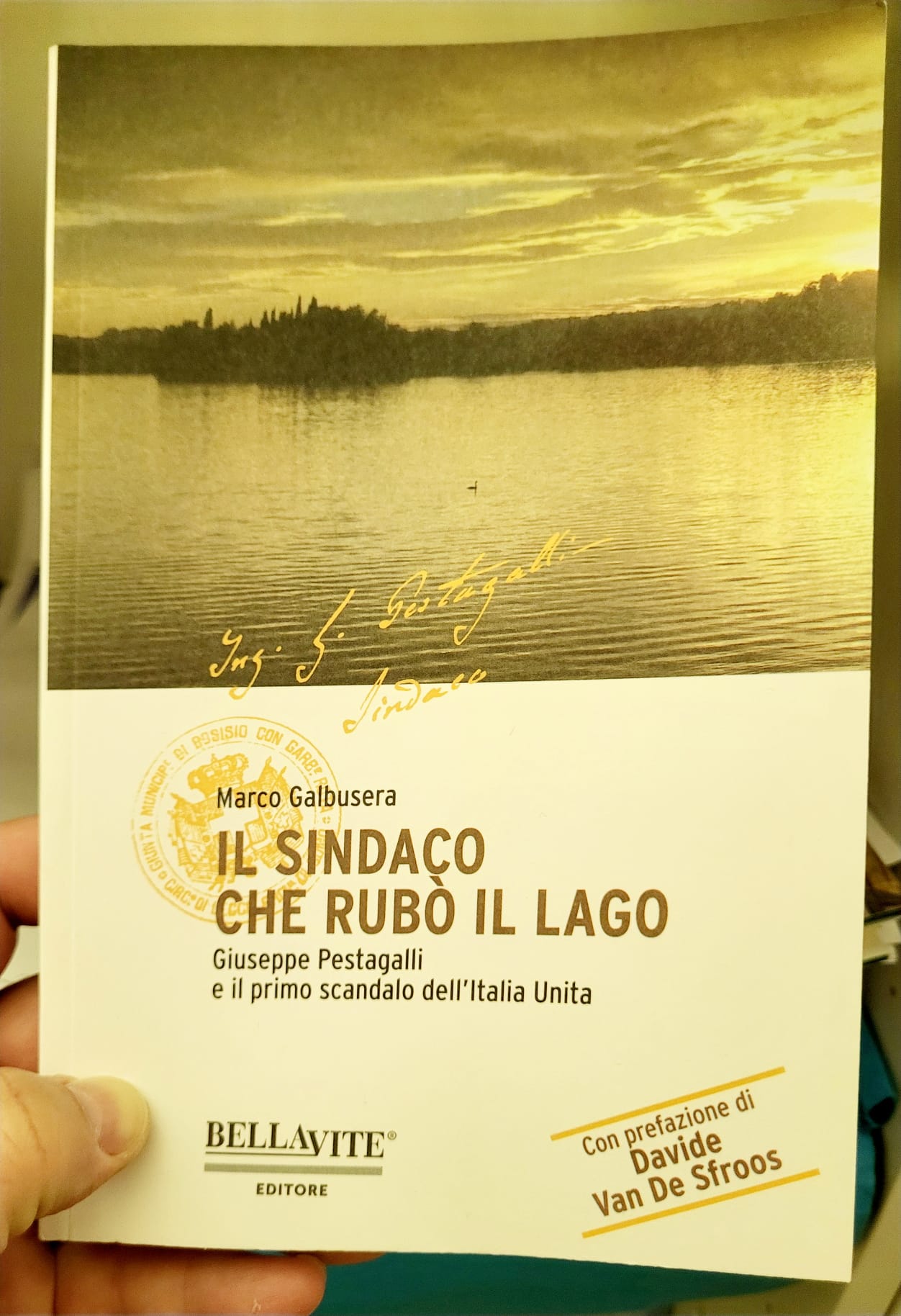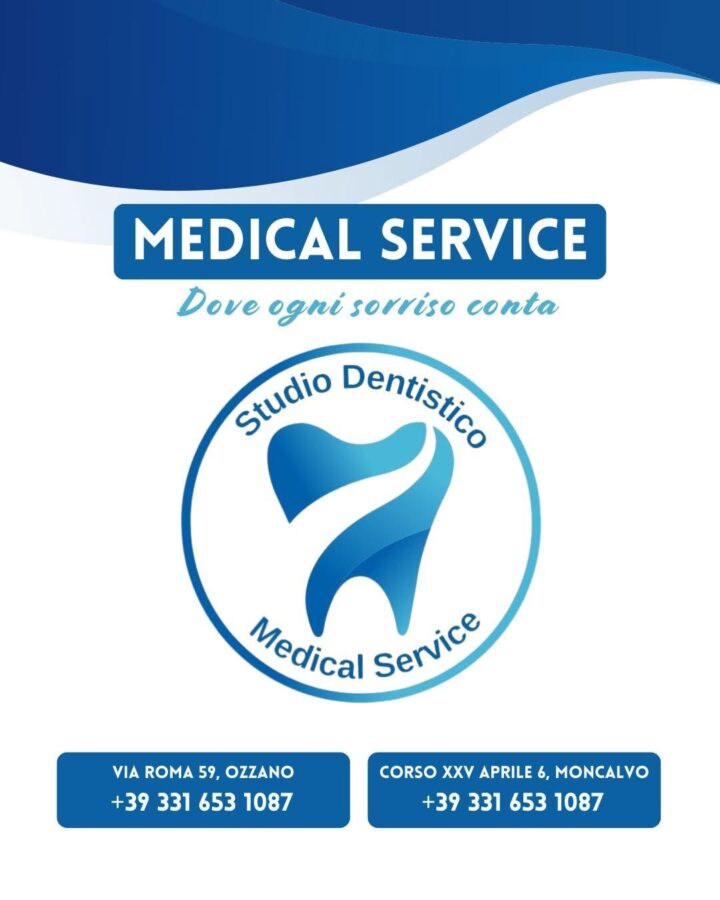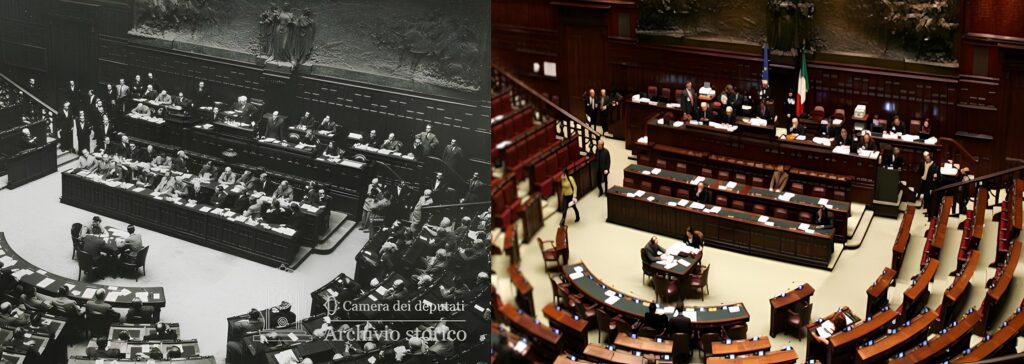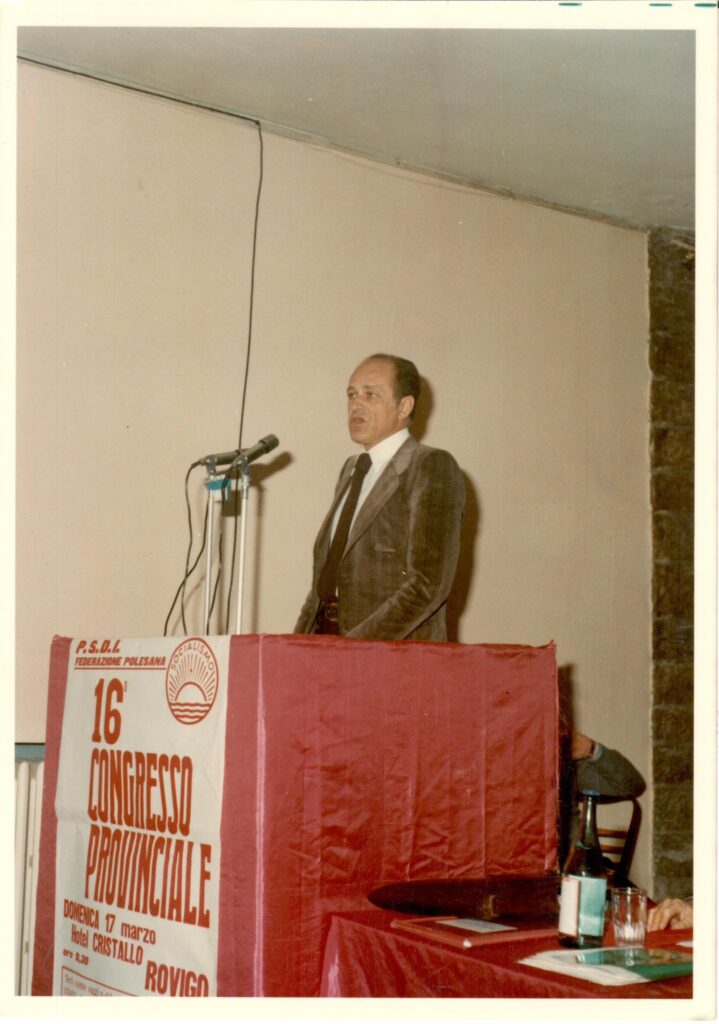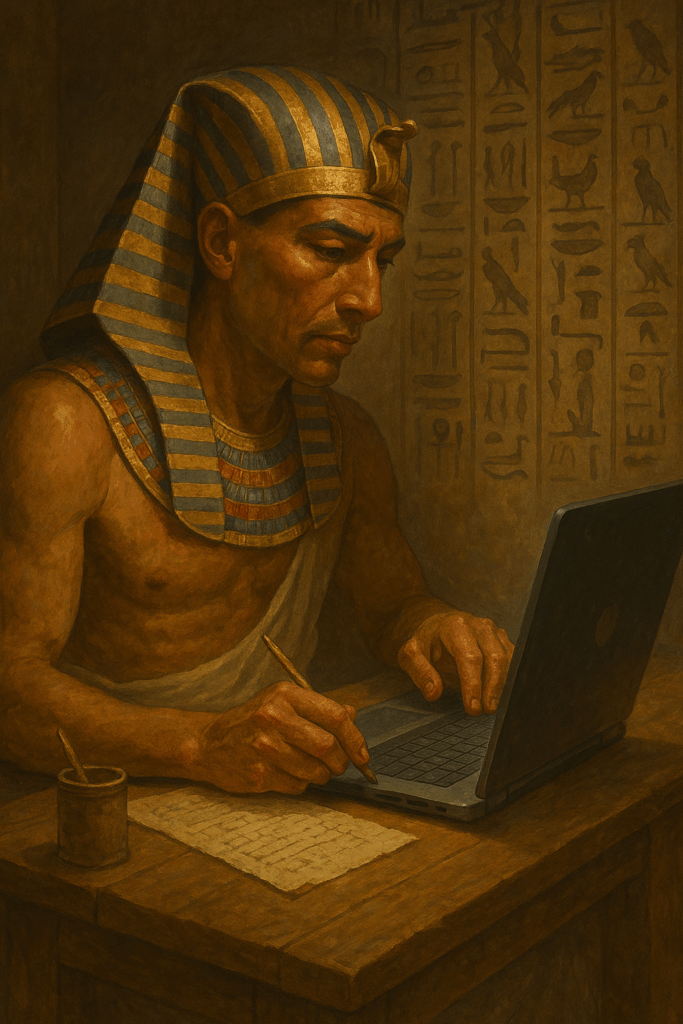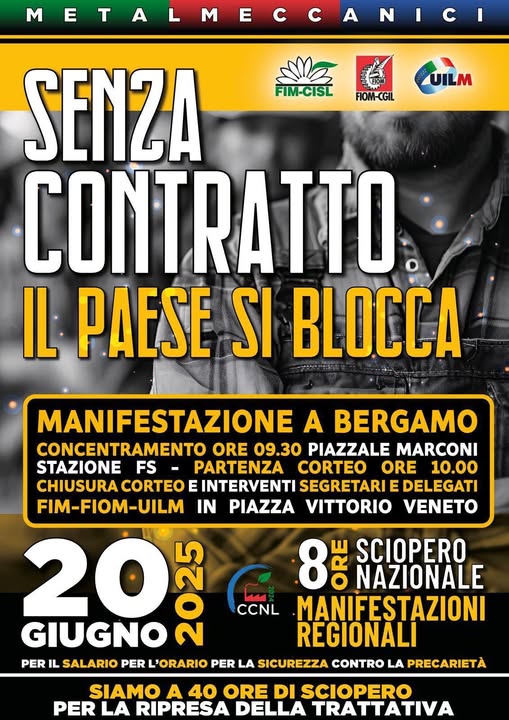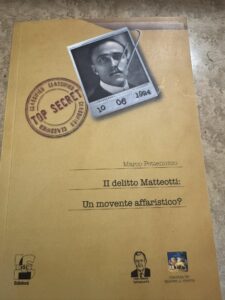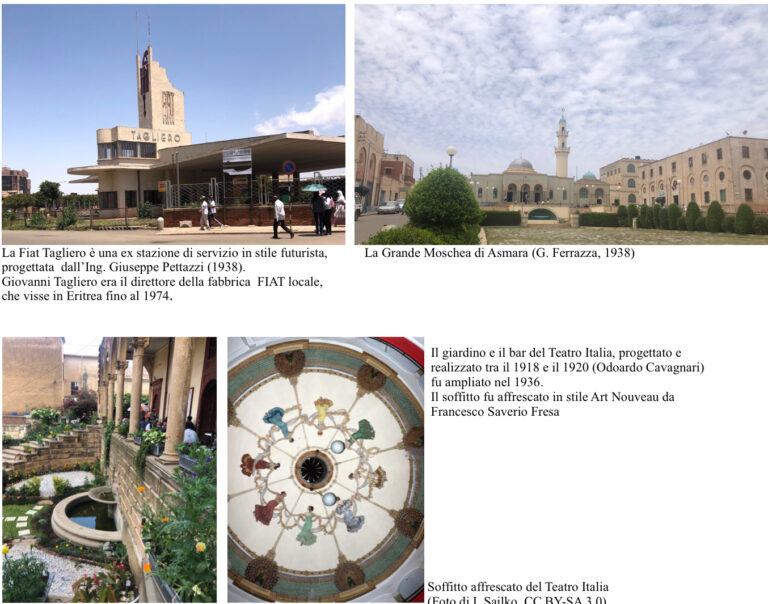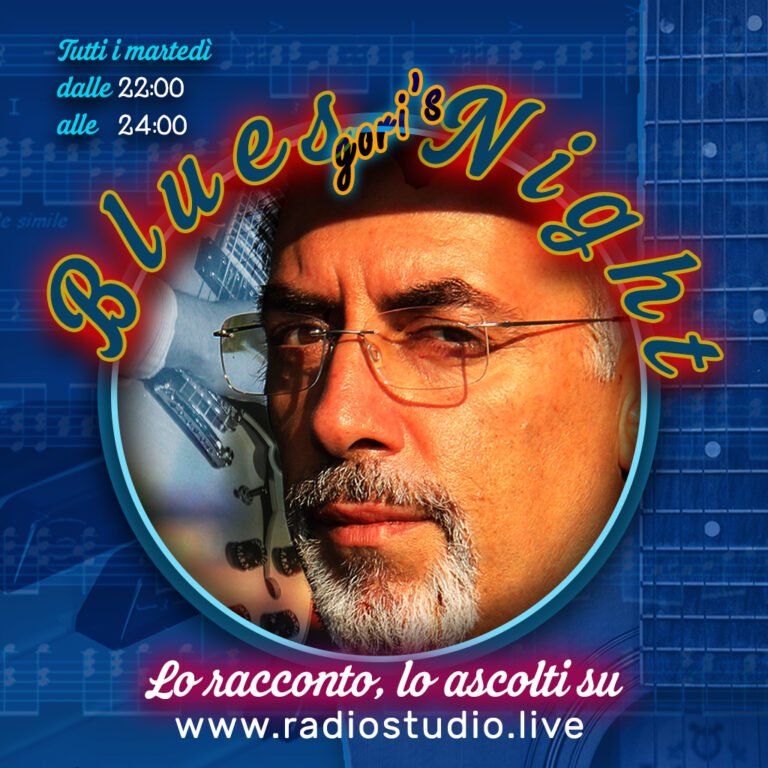di Matteo Rigamonti

Il libro di Marco Galbusera, Il sindaco che rubò il lago, non è solo un’opera di recupero storico su
uno scandalo dimenticato: è anche un prezioso strumento per riflettere sulla natura del potere
locale, sulle sue derive e, soprattutto, sulle sue continuità nel tempo.
La vicenda di Giuseppe Pestagalli, sindaco di Pusiano negli anni immediatamente successivi
all’Unità d’Italia, dimostra con chiarezza quanto i grandi cambiamenti politici e istituzionali non
coincidano automaticamente con un rinnovamento del modo di amministrare. L’Italia non era più
sotto dominio austriaco, ma il passaggio al sistema sabaudo non modificò sostanzialmente la
distanza tra amministrazione e cittadini. I sindaci non erano ancora eletti, ma nominati. La logica
era ancora quella dell’autorità calata dall’alto, lontana dal concetto moderno di rappresentanza.
Questo ci ricorda una verità fondamentale: i cambiamenti duraturi richiedono tempo, cultura e
consapevolezza. E il libro di Galbusera lo testimonia con efficacia, facendoci riflettere anche sul
presente.
In quel contesto, mancava inoltre un altro elemento essenziale della democrazia moderna: il ruolo
di controllo delle opposizioni. Le minoranze consiliari, come le intendiamo oggi, semplicemente
non esistevano. Non c’era alcuna forza politica o istituzionale incaricata di vigilare sull’operato
dell’amministrazione. Era dunque più facile che si verificassero situazioni opache, come quella
narrata nel libro. Anche il ruolo del segretario comunale – oggi figura chiave per la legalità e la
correttezza dell’azione amministrativa – all’epoca non aveva lo stesso peso tecnico-giuridico, o
comunque non fungeva da contrappeso reale. Forse perché si pensava che, essendo i sindaci
nominati dallo Stato, bastasse la loro “derivazione dall’alto” a garantire automaticamente il rispetto
delle leggi. Ma la storia di Pestagalli dimostra quanto questa fiducia fosse mal riposta.
Ecco perché questo libro parla anche al nostro tempo. Perché, se oggi la forma è cambiata, la
sostanza di certi comportamenti resta sorprendentemente simile. Ancora oggi si assiste – magari
con maggiore discrezione – a un uso distorto della funzione pubblica. Non sempre per malaffare:
spesso per impreparazione, per mancanza di consapevolezza. Alcuni amministratori, convinti di
fare del bene, confondono il loro ruolo con quello del benefattore, dell’uomo solo al comando.
Finiscono così per intervenire personalmente dove dovrebbero solo progettare, regolare, mediare.
Una confusione pericolosa tra pubblico e privato, tra dovere istituzionale e iniziativa personale.
La figura di Pestagalli, letta oggi, non appare tanto lontana: è il simbolo di un modo di intendere
l’amministrazione come proiezione del sé, e non come servizio alla collettività. È il riflesso di una
cultura in cui la legittimità del potere sembra derivare non dalle regole condivise, ma dalla capacità
individuale di “fare”.
E allora questo libro diventa utile non solo per capire il passato, ma anche per osservare il
presente con uno sguardo più lucido. Per ricordarci che la democrazia è fragile, che richiede
formazione, cultura delle regole e senso del limite. E che l’amministratore – oggi più che mai – è
chiamato a un contributo intellettuale, non materiale. Un ruolo che non ha bisogno di eroi, ma di
persone consapevoli.