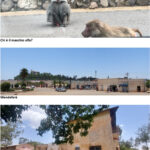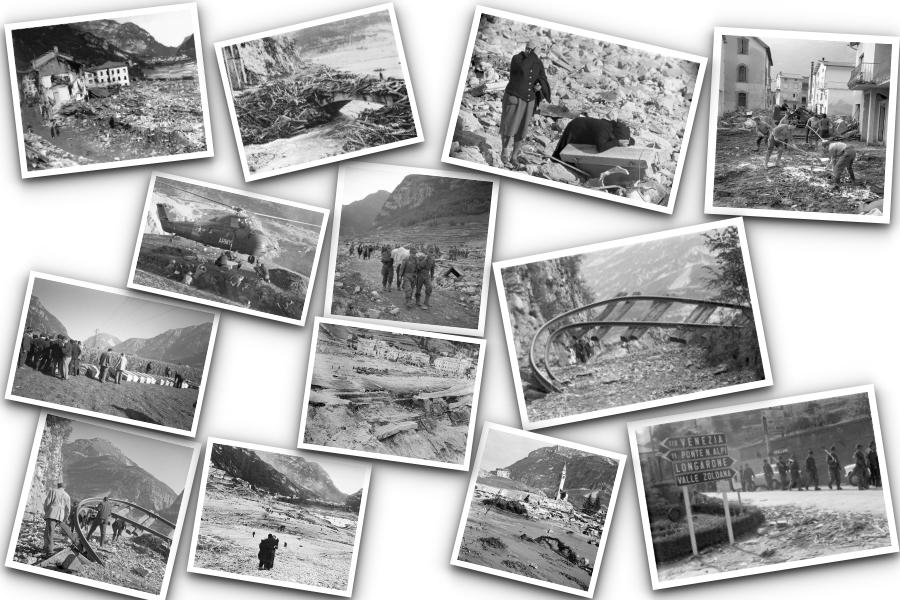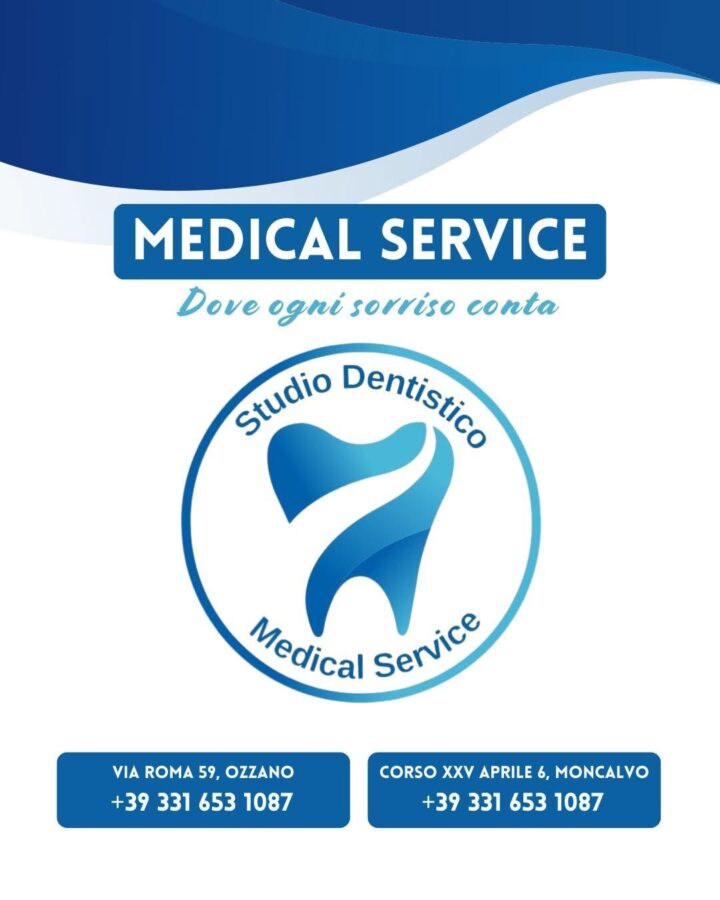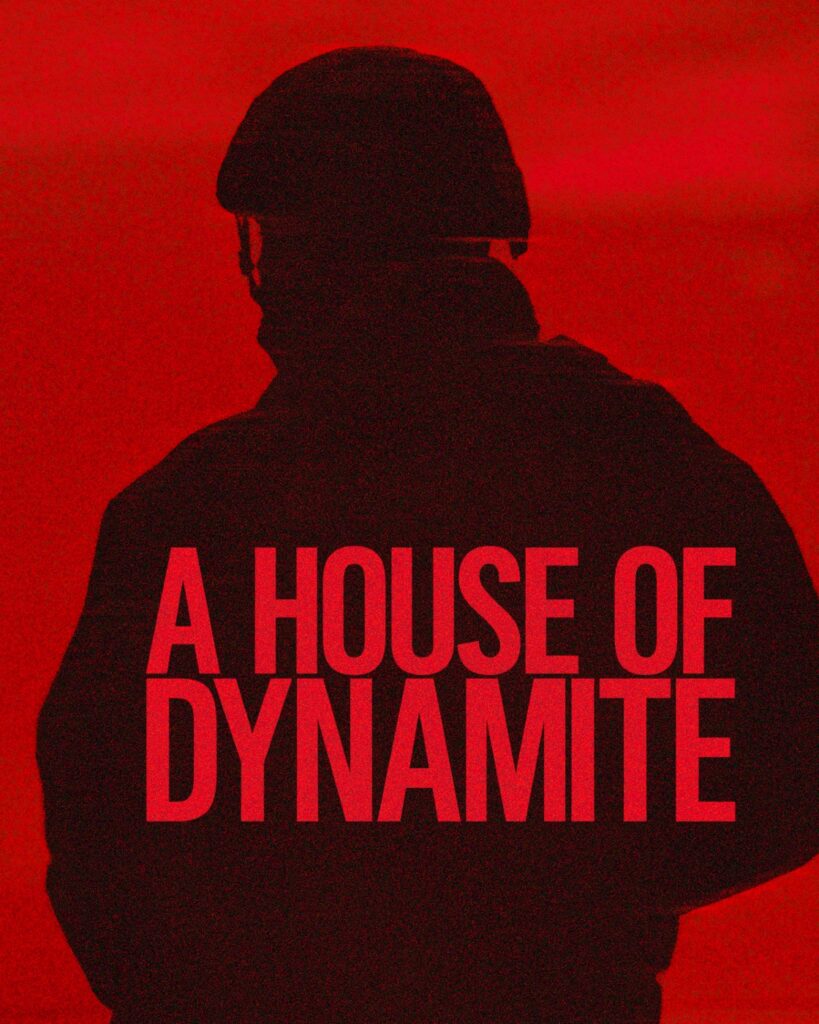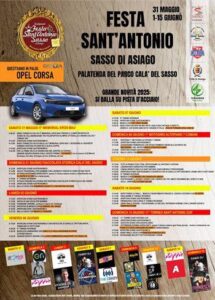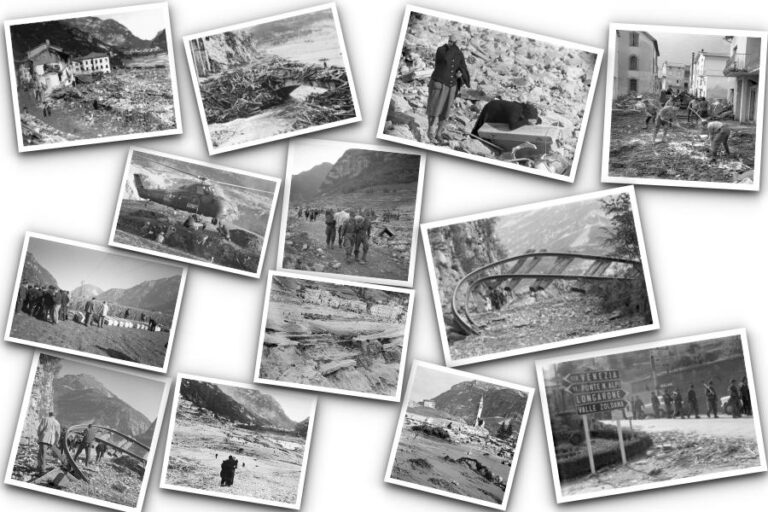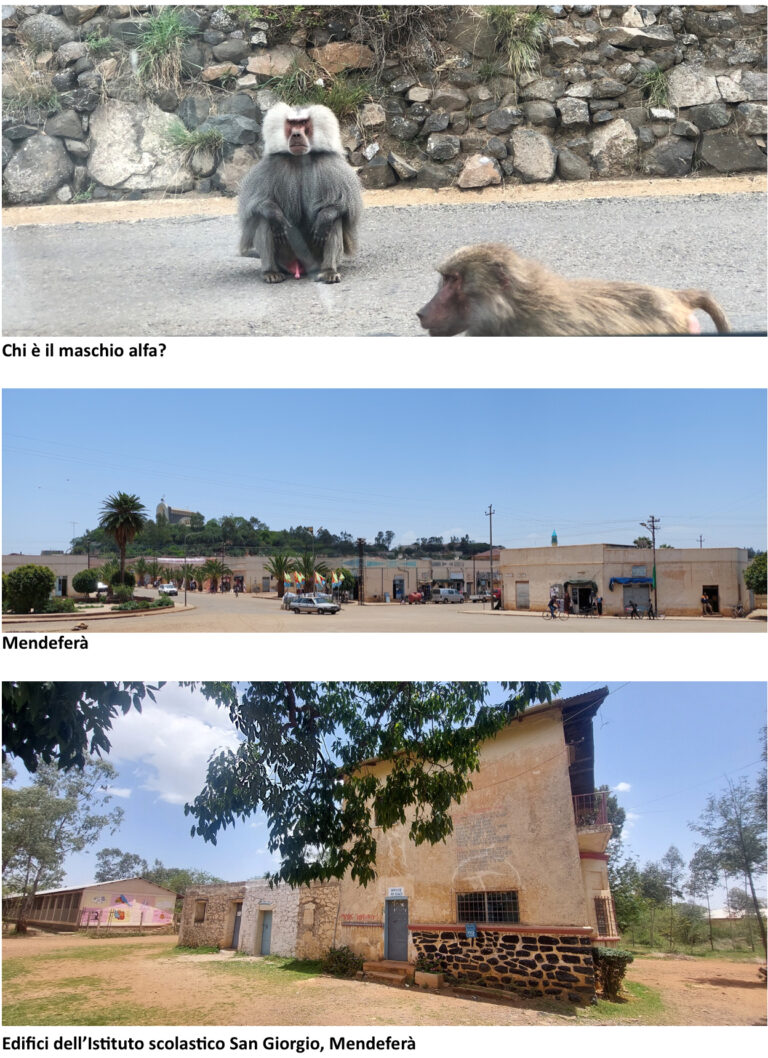di Nico Colani
Il 9 ottobre 2025, ricorre il 62° anniversario di una delle pagine più nere della storia
italiana: il disastro del Vajont. Quella notte del 1963, una frana colossale dal Monte Toc
travolse il bacino artificiale creato dalla diga del Vajont, generando un’onda mostruosa che
cancellò interi paesi e migliaia di vite. Non fu un atto della natura imprevedibile, ma il
risultato di errori umani, omissioni e un’ambizione tecnologica che ignorò i segnali di
allarme. In questo articolo, ripercorriamo la genesi del progetto, le sue gravi lacune, le
responsabilità, il bilancio umano, la reazione del Paese e il lascito di quella valle
trasformata per sempre. Un racconto per non dimenticare, affinché tragedie simili non si
ripetano.
La Nascita di un Gigante di Cemento: La Costruzione della Diga
L’idea di sfruttare le acque del torrente Vajont per produrre energia elettrica risale agli
anni ’20 del Novecento, ma fu solo nel dopoguerra che il progetto prese concretezza. La
Società Adriatica di Elettricità (SADE), controllata dal gruppo Montedison, affidò la
progettazione all’ingegnere Carlo Semenza, che nel 1940 delineò i primi piani per una diga
alta circa 200 metri. Approvato nel 1943, il progetto fu rivisto negli anni ’50 per renderlo
più ambizioso: l’altezza salì a 262 metri, con un bacino capace di 168 milioni di metri cubi
d’acqua, raccogliendo anche i flussi del Maè e del Boite attraverso il serbatoio di Pontesei. I
lavori iniziarono nell’estate del 1957 con gli scavi per le fondazioni, che si conclusero
nell’agosto 1958. La costruzione vera e propria, tra il 1958 e il 1960, diede vita a una diga a
doppio arco – una delle più alte al mondo all’epoca – con una corona di 3,4 metri di
spessore e un volume di 353.000 metri cubi di calcestruzzo. Situata al confine tra Veneto e
Friuli-Venezia Giulia, tra i comuni di Erto, Casso e Longarone, la struttura prometteva di
generare potenza idroelettrica per l’Italia in piena ricostruzione post-bellica. Nel 1962, con
la nazionalizzazione del settore elettrico, la gestione passò all’ENEL, che ereditò un
impianto già in fase di collaudo. Sembrava un trionfo dell’ingegneria italiana, ma sotto la
superficie geologica si nascondevano pericoli mortali.
Le Lacune del Progetto: Segnali Ignorati e Calcoli Sbagliati
Fin dall’inizio, il progetto fu viziato da gravi lacune geologiche e idrauliche. Gli studi
preliminari, condotti da esperti come Leopold Müller (1957) e Giorgio Dal Piaz (1958),
rivelarono l’instabilità del versante sinistro del Monte Toc: rocce calcaree fragili,
paleofrane antiche e strati argillosi (il “livello Fonzaso”) che separavano acquiferi instabili.
Müller avvertì di rischi di frane fino a 1 milione di metri cubi, ma i dati furono sottovalutati
o occultati dalla SADE per non ostacolare i lavori. Prospezioni geosismiche di Pietro Caloi
(1959-1960) inizialmente parlarono di rocce solide, ma rilevazioni successive mostrarono
fratture profonde fino a 150 metri. Errori fatali inclusero l’ignorare precedenti franosi,
come quella di Pontesei nel marzo 1959 (3 milioni di metri cubi, onda di 7 metri e un
operaio morto), che spinse i cittadini di Erto e Casso a formare un comitato di protesta. I
modelli idraulici in scala 1:200 (1961-1962) sottostimarono il volume della frana potenziale
(previsto max 40 milioni di metri cubi, reale 263 milioni) e la sua velocità (un terzo di
quella effettiva, 30 m/s). Mancarono drenaggi adeguati – un tunnel proposto da Müller
non fu pienamente attuato – e la SADE, insieme al Ministero dei Lavori Pubblici, approvò
il progetto nonostante prescrizioni per indagini ulteriori. La giornalista Tina Merlin, su
L’Unità, denunciò i rischi dal 1961, ma fu querelata per “procurato allarme”. In un contesto
di boom economico e nazionalizzazione, la fretta per i finanziamenti pubblici prevalse sulla
precauzione.

La Notte dell’Orrore: Il Bilancio Umano
Alle 22:39 del 9 ottobre 1963, durante la terza prova di invaso per raggiungere la quota 715
metri s.l.m., circa 263-270 milioni di metri cubi di roccia dal Monte Toc si staccarono a 90-
110 km/h, riversandosi nel bacino a quota 700 metri. L’impatto generò un’onda tricuspide
alta 250 metri, paragonabile a metà della bomba di Hiroshima per energia rilasciata. La
diga resistette – le forze furono 20 volte superiori al progetto –, ma l’onda superò la
corona, dividendosi: una risalì verso Erto e Casso, distruggendo borghi come Frasègn e
Prada; l’altra (25-30 milioni di metri cubi) devastò la valle del Piave, radendo al suolo
Longarone, Pirago, Faè, Villanova, Rivalta e parte di Belluno. Altezze variabili: 250 metri
nel bacino, 30 metri a Codissago, 25 metri a Pirago, 12 metri a Belluno. Il bilancio fu
tragico: 1.917 morti ufficiali (su base censuaria), tra cui 487 bambini e adolescenti, con
circa 1.300 dispersi e solo 1.500 corpi recuperati (metà irriconoscibili). Di questi, 1.450 a
Longarone, 109 a Codissago e Castellavazzo, 158 a Erto e Casso, e 200 da altri comuni. La
vittima più giovane aveva 21 giorni, la più anziana 93 anni; 64 erano dipendenti ENEL o
imprese collegate. Precedenti avvisi (ordinanza di sgombero a Erto l’8 ottobre) salvarono
parzialmente le zone alte, ma i paesi a valle non furono evacuati in tempo.
Responsabili e Prezzi Pagati:
Una Giustizia TardivaI principali colpevoli furono la SADE (poi ENEL), Montedison e il
Ministero dei Lavori Pubblici, accusati di aver occultato rischi noti per negligenza e dolo. Il
processo penale, iniziato nel 1968 all’Aquila per “legittima suspicione”, si concluse nel
1971: Alberico Biadene (direttore SADE) fu condannato a 6 anni per omicidio colposo
plurimo e inondazione (scontò 18 mesi, rilasciato per buona condotta); Francesco
Sensidoni (geologo ministeriale) a 4,5 anni (ridotti a 3 anni e 8 mesi). Altri come Mario
Pancini (ingegnere, suicidatosi nel 1968) e Pietro Frosini ricevettero pene minori o furono
assolti per insufficienza di prove. Le sentenze riconobbero l’evitabilità del disastro per
fallimento geologico e copertura di dati. Nei processi civili, protrattisi fino al 2000, ENEL e
Montedison (erede SADE) furono condannate in solido: Montedison pagò 55 miliardi di
lire a Longarone nel 1997; ENEL 480 milioni per beni patrimoniali a Erto-Casso e 500
milioni per danni ambientali. Un accordo finale divise i costi al 33,3% tra ENEL,
Montedison e Stato. L’archivio processuale (25.000 pagine) è patrimonio UNESCO dal
2023, simbolo di memoria globale.
La Reazione del Paese: Solidarietà e Rabbia
L’Italia reagì con un misto di orrore, solidarietà e indignazione. Dal 10 ottobre, Esercito,
Alpini e Vigili del Fuoco (850 uomini da 46 comandi) coordinarono soccorsi, con aiuti USA
da Aviano e Vicenza. Il Presidente Antonio Segni inviò telegrammi internazionali; raccolte
fondi: Corriere della Sera 1,16 miliardi di lire, L’Unità 965 milioni, RAI 640 milioni. Partite
benefiche come Inter-Milan mobilitarono lo sport. Politicamente, commissioni
parlamentari (dal PCI un “Libro bianco”) denunciarono il monopolio SADE e lo Stato; Tina
Merlin, assolta da accuse di “notizie false”, divenne eroina della denuncia. Giornalisti come
Indro Montanelli inizialmente la criticarono, ma si scusarono anni dopo. La società
riconobbe il disastro come “evitabile”, polarizzando destra e sinistra su imprevedibilità
versus prevedibilità. Il Futuro della Valle: Ricostruzione e Ombre Lunghe Longarone fu
rasa al suolo (salvati solo municipio e nord) e ricostruita ex novo su un piano rialzato,
grazie alla Legge 357/1964 (“Legge Vajont”), che fornì contributi (20% a fondo perduto,
80% agevolati) ed esenzioni fiscali, estesi a Veneto, Friuli e Trentino. Erto e Casso subirono
evacuazioni parziali; nel 1971, sfollati formarono il Comune di Vajont presso Maniago,
mentre una “Nuova Erto” nacque come quartiere di Ponte nelle Alpi. Sopra l’antica Erto
sorse il paese attuale, ma con spopolamento e traumi psicologici persistenti. La diga,
inutilizzata, è un memoriale; la valle cambiò demograficamente, con nuove aziende e 900
miliardi di lire in transazioni finali nel 2000. Oggi, mostre, libri e film come quello di
Marco Paolini custodiscono la memoria.
Un Monito per le Generazioni Future
Il Vajont, definito dall’ONU nel 2008 “evitabile” per fallimento di ingegneri e geologi,
insegna l’urgenza di indagini geologiche complete in zone a rischio, considerando
paleofrane, piogge e impatti idrici. Monito contro sottovalutazioni nei modelli, mancanza
di trasparenza e di profitti su vite umane – echi in disastri come Stava (1985) o dibattiti su
trivelle e TAV. In un’era di cambiamenti climatici, ricorda: l’uomo può domare fiumi, ma
non ignorare la terra che parla. Che questa valle ferita sia lezione eterna per un’Italia più
cauta e giusta.